Il Senato della Repubblica, nella seduta di mercoledì 17 settembre 2025, ha approvato definitivamente il disegno di legge recante “disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, collegato alla manovra di finanza pubblica.
Per l’Italia si tratta della prima normativa nazionale in materia di A.I.
Il testo è composto da 28 articoli suddivisi in sei capi che non disciplina direttamente l’uso dell’A.I. ma affida al Governo la responsabilità di adottare decreti attuativi per regolare diversi settori.
I punti chiave del nuovo testo di legge sono rappresentati da:
- un approccio antropocentrico: l’A.I. deve essere uno strumento a supporto delle decisioni senza sostituirsi all’intervento umano.
- un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell’A.I.
- necessità di garantire i diritti fondamentali, la non discriminazione, la parità dei sessi, la sicurezza, la responsabilità umana, la protezione dei dati personali, la riservatezza, l’accuratezza e la sostenibilità.
Le autorità nazionali competenti sono l’AgID, quale Autorità di notifica e regolamentazione, e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), per i profili di vigilanza e ispezione.
I settori individuati dal legislatore sono quattro: la sanità, il lavoro, la Pubblica Amministrazione e la giustizia, la scuola e lo sport.
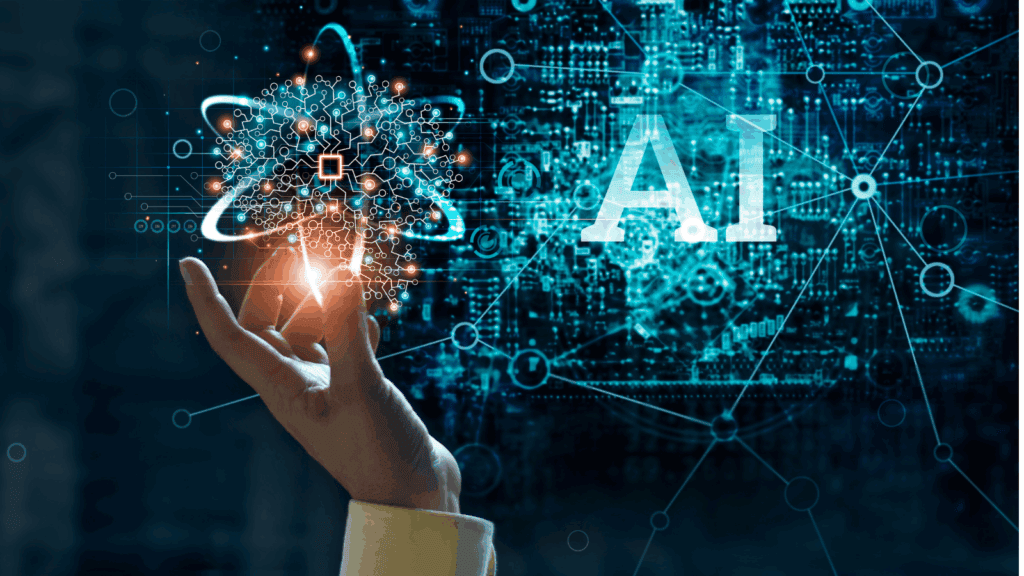
Le principali novità in tema di lavoro
Articolo 11 – Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro
- Si stabilisce che l’intelligenza artificiale viene impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.
- L’utilizzo dell’A.I. in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
- Il ricorso all’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro deve in ogni caso garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.
Articolo 12 – Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro
- Sarà istituito un Osservatorio ministeriale con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale.
Articolo 13 – Disposizioni in materia di professioni intellettuali
- L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali dovrà essere finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
- Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Altri insights correlati:
- Intelligenza Artificiale e lavoro: le Linee Guida del Ministero tra innovazione e tutela dei diritti (Econopoly de Il Sole 24 Ore, 27 agosto 2025 – Martina De Angeli, Alesia Hima)
- Come gestire l’intelligenza artificiale in azienda: guida per dirigenti (Agenda Digitale – 4 aprile 2025, Martina De Angeli)
